Il pallone racconta: METODO E SISTEMA (seconda parte)

Al concetto della “piramide” s’ispira sensibilmente anche il “metodo”, che resterà alla base del calcio italiano sino alla seconda guerra mondiale e che frutterà agli Azzurri la conquista di due titoli mondiali, nel 1934 e nel 1938.
Il “metodo” viene anche chiamato “modulo a W”, perché la disposizione dei giocatori in campo disegna in pratica una doppia “W” sovrapposta. Davanti al portiere, come nella “piramide”, si sistemano i due terzini, che presidiano la propria area di rigore senza specifici impegni di controllo nei confronti degli avversari. La linea mediana è, però, diversamente articolata. I due mediani laterali, infatti, si allargano sulle due opposte fasce di campo e finiscono per controllare direttamente gli attaccanti esterni avversari, vale a dire le “ali”. Il mediano centrale, o centromediano, è leggermente più arretrato rispetto ai laterali, in una posizione intermedia fra loro ed i terzini.
Questa figura è particolarmente esaltata dal “metodo” ed, infatti, resterà nella storia del calcio con la definizione di “centromediano metodista”. È il perno di tutta la squadra. Dirige la difesa e funge, in sostanza, da frangiflutti nei confronti degli attacchi frontali avversari; è anche, però, l’uomo incaricato di capovolgere il fronte del gioco, con lunghi rilanci che in genere mettono in movimento i due interni, dai quali la manovra è poi trasmessa alle ali e conclusa con i cross per il centravanti.
Mentre nella “piramide” i cinque attaccanti erano disposti sulla stessa linea, il “metodo” prevede i due interni, o mezzeali, arretrati rispetto alle ali ed al centravanti, in modo da presidiare il centrocampo, zona nevralgica del terreno di gioco. Se dunque la “piramide” era sintetizzabile con la formula del “2-3-5”, il “metodo” è più articolato: “2-3-2-3”, con un equilibrio teoricamente perfetto fra i giocatori di difesa e quelli di attacco.
Sono le doti individuali del centromediano a fare sovente la differenza in campo. Luisito Monti, “la roccia che cammina”, medaglia d’argento olimpica (1928) e vice-campione del mondo (1930) con la Nazionale argentina, diventa campione del mondo in maglia azzurra nel 1934 e trascina la Juventus a quattro scudetti consecutivi, dal 1932 al 1935.
Agonisticamente fortissimo, dotato di una battuta potente e precisa e di una personalità votata al comando, è il tipico interprete di questo ruolo, che richiede carisma non meno che buona tecnica e spiccate doti atletiche. Nel centromediano metodista confluiscono in pratica due ruoli del calcio moderno: quello di “regista” di centrocampo e di “libero” difensivo.
Nel periodo fra le due guerre, mentre gli inglesi stavano già gettando le basi di una nuova rivoluzione tattica (cioè il passaggio al “sistema” a “WM”), le due più grandi interpreti europee del “metodo” furono l’Italia di Vittorio Pozzo, campione mondiale nel 1934 e nel 1938, e l’Austria di Hugo Meisl, il “Wunderteam”.
Mentre l’Italia lo onorava con due titoli mondiali, il “metodo” era già virtualmente superato in Inghilterra, a partire dagli anni trenta e, sotto la decisiva spinta dell’Arsenal, tutte le squadre si erano convertite ad un nuovo verbo tattico.
La svolta ebbe origine da una decisione dell’International Board, l’ente preposto ai regolamenti internazionali che, nel 1925, effettuò uno dei suoi rari interventi sullo spirito originario del gioco e modificò la norma del fuorigioco. Sino ad allora, perché un attaccante fosse ritenuto in posizione regolare, occorreva che al momento in cui partiva il passaggio destinato a raggiungerlo avesse tre avversari (normalmente due più il portiere) fra sé e la porta “nemica”. Una regola assai penalizzante per il gioco d’attacco; bastava, infatti, che uno dei due terzini avanzasse, lasciando l’altro a protezione dell’area, perché il centravanti fosse, sistematicamente, in posizione irregolare. Come conseguenza, si era sviluppato l’orientamento a tenere il centravanti arretrato, in pratica in veste di rifinitore per le mezzeali che, partendo da lontano, potevano arrivare al goal senza cadere nella trappola del fuorigioco. L’International Board ridusse a due (in pratica uno, più il portiere) il numero dei difensori che l’attaccante doveva avere fra sé e la porta avversaria e stabilì che non esisteva fuorigioco nella propria metà campo. Un’impostazione che regge tuttora, come un cardine, l’intero regolamento del calcio.
Nel fervore di novità che questa modifica produsse, determinando un nuovo slancio per il gioco offensivo, s’inserì uno studioso di calcio inglese, Herbert Chapman (mediocre ex calciatore, ma geniale stratega), che l’Arsenal ingaggiò sulla meta degli anni venti, per risollevare le sorti del club. Trovando i giocatori adatti, Chapman preparò un nuovo modulo di gioco, che prese appunto il nome di “Chapman system” o, più semplicemente, “sistema”.

Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
Editore: TMW NETWORK s.r.l. - P.I. 02210300519
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26208
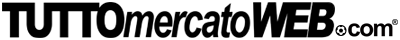
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus F.C. S.p.A.


















