Il pallone racconta: METODO E SISTEMA (prima parte)

La storia del calcio è scandita dall’evoluzione degli schemi tattici via via interpretati dalle varie squadre. Nato alla fine dell’ottocento nei college inglesi, il calcio non aveva neppure regole, figurarsi schemi. Nei college inglesi si giocava un misto di calcio e rugby, secondo codici che variavano da istituto ad istituto. L’aspetto tattico era del tutto sconosciuto, come anche lo spirito collettivo del gioco. Chiunque avesse il possesso della palla, iniziava un’azione individuale verso il settore avversario, sino al completo esaurimento delle risorse fisiche.
La fondazione della Football Association, nel 1863, permise di separare il calcio dal rugby, attraverso poche ma elementari regole: i giocatori dovevano essere undici (secondo un’interpretazione, undici erano gli allievi per ogni camerata), l’uso delle mani era riservato soltanto ad uno di loro, chiamato “goalkeeper”, o portiere, gli assalitori (è presto per parlare di attaccanti) non dovevano essere più vicini alla porta avversaria dei difensori. Quest’ultima regola è la più antica versione dello “off-side”, o fuorigioco, una norma che subì successive modificazioni ed, ancor oggi, è fonte di accanite discussioni e di vivacissime polemiche.
Questa prima forma di calcio, già ancorata a principi fondamentali non più modificati, ignorava però del tutto l’aspetto tattico. Gli undici giocatori si disponevano alla rinfusa, soltanto il portiere aveva una sua logica caratteristica. In una fase successiva, davanti al portiere, si disposero, in verticale, altri due giocatori, mentre gli altri otto erano unicamente proiettati all’attacco. Applicando le formule odierne, potremmo parlare di “1-1-8”. Se pensiamo che il modulo più frequente ai tempi nostri è il “4-4-2”, possiamo concludere che la mentalità offensiva, nel calcio, ha innestato una continua retromarcia. Furono gli scozzesi a modificare, per primi, lo schieramento base, raddoppiando i difensori e costituendo, così, due successive coppie davanti al portiere: “2-2-6”, sempre col metro di oggi. Indipendentemente dalla posizione assunta sul campo, il modo di giocare prescindeva da ogni forma di collaborazione fra i reparti.
Quest’epoca del calcio è etichettata con lo slogan “kick and yusc”, traducibile in “calcia e corri”; un gioco assolutamente spontaneo, frutto della libera iniziativa di ogni singolo giocatore. Gli stessi difensori si limitavano a rilanciare il pallone in avanti, senza organizzare una valida contromisura ai numerosissimi attaccanti che invadevano il loro settore.
Nei college inglesi, questo tipo di gioco era chiamato anche “dribbling game”, dato che la sua figura principale consisteva nell’azione individuale, che il possessore di palla intraprendeva cercando di evitare, o dribblare, quanti più avversari potesse, senza chiedere o cercare la collaborazione dei compagni.
Il passo successivo fu fondamentale.
Dal “dribbling game” si arrivò, sempre con la decisiva incidenza degli scozzesi, al “passing game”, in altre parole al gioco basato sui passaggi fra i compagni di squadra. Ed è con il “passing game” che, in pratica, il calcio inizia il suo lungo viaggio attraverso gli affascinanti segreti della tattica. Il fatto che il calcio fosse giocato prevalentemente in ambiente universitario, facilitò la sua progressiva evoluzione tecnica e tattica. Il momento agonistico, infatti, era studiato con attenzione, in un’ansia comprensibile di perfezionamento. Proprio da uno dei più celebri college d’Inghilterra, Cambridge, scaturì un’impostazione che è rimasta fondamentale in tutta la storia del calcio. Ci si era accorti, infatti, che con l’adozione del “passing game” la disposizione dei giocatori doveva trovare un assetto più razionale, in modo da favorire la collaborazione fra chi agiva nelle varie zone del campo. Nacque cosi, appunto a Cambridge, l’idea della “piramide”.
Davanti al portiere erano schierati due difensori (o “backs”), incaricati di presidiare il settore di campo più vicino alla propria porta; poco più avanti, c’era una linea di altri tre giocatori, (“halfbacks”), che dovevano raccogliere le respinte dei due difensori e trasformarle in suggerimento per la linea di attaccanti (o “forwards”) composta da cinque uomini, disposti sull’intera larghezza del campo.
Al momento di importare in Italia quest’impostazione (“2-3-5”), si parlò di prima linea per gli attaccanti, di linea mediana per i tre giocatori intermedi, che furono appunto chiamati mediani, mentre i due ultimi difensori, costituendo la terza linea, presero il nome di terzini.
Lo schema grafico che rappresenta questa disposizione tattica, passando da un giocatore schierato (portiere), a due (terzini), a tre (mediani), a cinque (attaccanti), assume la forma di una piramide rovesciata. E “piramide” fu, infatti, il nome con cui questa tattica di gioco dilagò in tutta Europa.
Va, però, precisato che se la “piramide” ha già in sé molti motivi di modernità, non presenta ancora un concetto che diverrà imprescindibile nel calcio: la marcatura, in pratica l’accoppiamento di un proprio difensore ad uno specifico attaccante avversario. In questo senso, la “piramide” è già un anticipo dello schieramento “a zona”, che soltanto molto più tardi irromperà nel calcio.
La “piramide di Cambridge” va considerata la prima vera tattica moderna del calcio; dall’Inghilterra si diffuse a macchia d’olio in tutta Europa, approdando logicamente anche in Italia. La prima squadra di alto livello che applicò la “piramide” fu il Blackburn Rovers, che lo utilizzò, per la prima volta, nel 1884 ed arrivò a vincere cinque coppe d’Inghilterra, tra gli anni ottanta e novanta dell’ottocento. Sull’entusiasmo di questi successi, la tattica della “piramide” conobbe ininterrotta fortuna nelle isole britanniche e, di riflesso, nel mondo intero per oltre un trentennio. In America meridionale, invece, la piramide tenne ancora a lungo la scena, soprattutto per merito delle nazionali di Uruguay ed Argentina, vere e proprie superpotenze del calcio continentale e mondiale negli anni venti e trenta. In quegli anni le due nazionali platensi furono capaci di dominare numerose edizioni della Coppa America, le Olimpiadi (1924 e 1928) e la prima edizione dei mondiali di calcio, nel 1930.

Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
Editore: TMW NETWORK s.r.l. - P.I. 02210300519
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26208
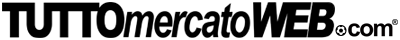
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus F.C. S.p.A.


















