Il pallone racconta: METODO E SISTEMA (terza parte)

La figura importante è, ancora una volta, il centromediano. Esso è arretrato sulla linea dei terzini, che si allargano sulle fasce laterali. Il centromediano si piazza, così, nel cuore della difesa e si prende direttamente cura (ad uomo, come si direbbe oggi) del centravanti avversario; nasce lo “stopper”. Contemporaneamente, i due mediani laterali avanzano e formano, con le due mezzeali, un quadrilatero di centrocampo. Con la solita formuletta, possiamo parlare di “3-2-2-3”. Se, invece, ricorriamo alla rappresentazione grafica, vediamo che in campo si disegna non più una doppia W, ma una W e una M. Ed è, infatti, con il nome di “WM” che il “sistema” inglese è conosciuto nel mondo.
Può sembrare un dettaglio insignificante il cambio di posizione rispetto al “metodo” di alcuni giocatori; in realtà, è tutta la filosofia del gioco che è innovata. Le marcature diventano individuali, rigorose ed, a volte, asfissianti. La contrapposizione “uomo contro uomo” rende molto più aggressive le squadre che adottano il “sistema”, rispetto a quelle schierate tradizionalmente secondo il “metodo”.
In Inghilterra il successo è immediato. L’Arsenal, che aveva conosciuto un lunghissimo e profondo declino, con i dettami di Chapman instaura un ciclo vittorioso, conquistando la Coppa d’Inghilterra nel 1929-30 e tre titoli assoluti in quattro anni, dal 1930 al 1934; logicamente, le sue sfavillanti vittorie spingono tutte le squadre inglesi ad imitarlo.
In Italia il processo fu più lento. Vittorio Pozzo riteneva che il “metodo” esaltasse le peculiarità degli italiani, in quanto portava ad un gioco meno fisico rispetto al sistema e, per certi versi, meno accademico, caratterizzato invece da una robusta difesa e rapidi contropiede. Infatti, mentre le squadre “sistemiste” raccoglievano applausi per l’eleganza dei loro giocatori, che costruivano la manovra tessendo una fitta ragnatela di brevi passaggi, le squadre “metodiste” erano più opportuniste e, spesso, concrete. Lanci lunghi che partivano dai difensori o dal centromediano giungevano ai centrocampisti avanzati oppure alle ali. Questi ultimi, rapidamente, servivano l’attaccante che finalizzava la manovra; in tutto non più di tre o quattro passaggi prima di scoccare il tiro a rete.
In campionato, soltanto il Genoa si convertì quasi subito al nuovo verbo, ottenendo, in effetti, eccellenti risultati, rispetto alla caratura tecnica della squadra. Nel maggio del 1939, l’Italia “metodista” affrontò, a Milano, l’Inghilterra portacolori del “sistema”.
Gli inglesi dominarono la partita e soltanto un goal realizzato da Piola con la mano (irregolarità sfuggita all’arbitro) ci consentì di pareggiare. Sotto la spinta dei riformisti, Pozzo fu, in pratica, costretto a sposare il “sistema”. Lo fece di controvoglia e la sconfitta rimediata a Berlino contro la Germania, il 26 novembre 1939, con un’Italia confusamente schierata secondo il “WM”, gli fece fare una precipitosa marcia indietro. Di “sistema”, per l’Italia, si sarebbe riparlato dopo la seconda guerra mondiale.
Nell’Italia dell’immediato dopoguerra, il miglior ambasciatore del “sistema” fu il “Grande Torino”, dominatore incontrastato della scena nazionale sino al 1949, quando lo schianto di Superga distrusse una delle squadre più leggendarie della storia del calcio. In effetti, si scambiò per merito della tattica quello che era in gran parte frutto della superiore qualità individuale dei giocatori. Quel Torino, è ragionevole pensare, avrebbe vinto scudetti in serie adottando qualsiasi modulo, dalla “piramide” in poi, tanto netta era la sua superiorità sul resto del lotto. Per la cronaca, comunque, quello granata del 1943, prima dell’interruzione bellica, fu il primo scudetto “sistemista” del calcio italiano.
La critica nazionale era ferocemente divisa fra “metodisti e “sistemisti”, anche se i secondi andavano prendendo progressivamente il sopravvento. L’intuizione di Pozzo doveva, però, rivelarsi esatta. Il “sistema puro” non era congeniale al calciatore italiano, poiché privilegiava eccessivamente l’atletismo sulla tecnica e sulla raffinatezza tattica, tipiche qualità dei nostri giocatori. Sicché, dopo la conversione in massa al “sistema” (anche da parte della Nazionale che, dopo le disastrose Olimpiadi del 1948, aveva silurato Vittorio Pozzo), cominciarono subito le varianti e le correzioni, per trasferire nell’originario modulo inglese le nostre ataviche malizie.
Già nel 1944, vincendo un campionato di guerra non omologato ufficialmente, la squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia, allenata dall’ex genoano Barbieri, aveva applicato il “mezzo sistema”, un riuscito ibrido fra “metodo” e “sistema”. Qualcosa di simile adottò anche il Modena della stagione 1946-47, che schierava un terzino, Remondini, a guardia del centravanti avversario e l’altro, Braglia, in seconda battuta. Quel Modena arrivò terzo, miglior risultato di tutta la sua storia.
Da allora, fu un susseguirsi di strategie e schemi, studiati da grandi tecnici ed esaltati da inarrivabili campioni. Ogni tattica è legata al ricordo della squadra che meglio l’ha interpretata: il “metodo” all’Italia di Pozzo; il “sistema”, che rivoluziona il calcio sul finire degli anni venti, all’Arsenal di Herbert Chapman; il “catenaccio” alla Svizzera di Karl Rappan, bella protagonista, pur senza grandi talenti, ai Mondiali del 1938; il “4-2-4” al mitico Brasile di Pelè, dominatore assoluto dei due Mondiali del 1958 e del 1962; il “calcio totale” all’Olanda di Cruijff, grandissima ma sfortunata primattrice degli anni settanta; la “zona” di Arrigo Sacchi, alla fine degli anni ottanta, che cambia il calcio italiano.
Ma, c’è un filo comune che lega tutto questo; si possono cambiare schemi e strategie ma, alla fine, la differenza la fanno sempre i fuoriclasse.

Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
Editore: TMW NETWORK s.r.l. - P.I. 02210300519
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26208
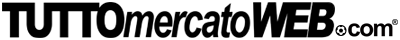
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus F.C. S.p.A.


















