Gli eroi in bianconero: Lionello MANFREDONIA

Lionello Manfredonia: uno, nessuno, centomila – scrive Nicola Calzaretta sul “Guerin Sportivo” del 25-31 agosto 2009 –. Difensore, centrocampista, giocatore universale. Dalla Lazio alla Roma, passando per la Juventus dell’ultimo Platini. Precocemente avviatosi al calcio sorretto da un talento non comune, per il biondino nato ai Parioli. Scudetto Primavera e la Serie A con la Lazio, la Nazionale maggiore: tutto d’un fiato, intorno ai vent’anni. Poi, sul più bello, l’entrata sbagliata proprio sotto il naso dell’arbitro: rosso inevitabile. Un’ingenuità che lo ha condotto dritto nel girone dei calciatori maledetti, con tanto di squalifica per una brutta storia, forse più grande di lui.
Due anni senza calcio, due stagioni senza pallone, quindi il rientro. Non più cattivo ragazzo, ma uomo maturo e catarticamente riconciliatosi con il mondo. Una purificazione a tutto tondo. Una nuova vita pallonara per lui che, nato stopper, si è nel frattempo mutato in efficace mediano con licenza di segnare. Scudetto, coppe, la speranza di tomare in azzurro. Poi il blackout in un freddissimo pomeriggio bolognese. All’età di 33 anni, quelli di Cristo, che è morto ed è risorto più di duemila ami fa. Il 30 novembre 1989 è toccato a Lionello Manfredonia risorgere dopo aver rischiato seriamente di morire.
Che ricordi ha di quel pomeriggio? «Ricordo il viaggio Roma-Bologna con il Pendolino. Una scelta diversa dal solito, il treno non si prendeva quasi mai per le trasferte. Quindi il ritiro, la preparazione della partita, cose normali, consuetudinarie. Poi c’è un buco di due, tre giorni, quando mi sono risvegliato dal coma in ospedale».
Chi ha visto per primo quando ha riaperto gli occhi? «Il mio amico ed ex compagno di squadra Fulvio Collovati».
Collovati? Un incubo! (risata). «In quei giorni oltre ai miei familiari, so che sono venute tantissime persone a farmi visita. Cabrini passò lì la notte di San Silvestro. Sono rimasto molto colpito dai tanti gesti di amicizia e solidarietà. Non me l’aspettavo».
Ma alla fine cosa le è successo? «Nei primi bollettini medici si è parlato di infarto, ma la diagnosi vera è di arresto cardiaco. È andata così, senza che ci fossero stati segnali premonitori».
Lei che spiegazione si è dato? «Quella domenica faceva molto freddo ed io avevo un po’ di febbre. In più avevo accumulato quantità enormi di stress, senza dimenticare che poco tempo prima era morta mia madre. Credo che sia stato un insieme di cause, perché, ripeto, mai prima di quel giorno avevo avuto problemi cardiaci, né di altro tipo. Per fortuna l’angelo custode non mi ha abbandonato».
A chi deve la vita? «Intanto al fatto che ci fosse un defibrillatore a bordo campo, fatto eccezionale per quell’epoca. E poi ai medici e massaggiatori di Roma e Bologna e ai dottori dell’Ospedale Maggiore di Bologna. In particolare Giorgio Rossi, che mi ha praticato la respirazione bocca a bocca, e il dottor Naccarella che mi ha riattivato il cuore al quinto tentativo».
Al risveglio ha voluto subito sapere cosa le era accaduto? «Ho chiesto cosa avesse fatto la Roma e una sigaretta. Poi mi sono fatto raccontare tutto. Così sono tornati lentamente alla memoria i ricordi dell’incidente. Per fortuna ho recuperato molto velocemente. Sono tornato a vivere presto. Sono rinato come persona quello sì, ma sono morto come calciatore. Purtroppo».
Le brucia molto? «Sì. Mi rode che mi abbiano proibito di giocare. Stavo benissimo, ero tranquillo e avevo una voglia matta di pallone. Mi hanno fermato i medici, ma io ero pronto a prendermi tutte le responsabilità pur di non smettere. Quello di Bologna è stato un episodio. Ho sempre fatto vita da atleta. Mai fumato, né bevuto».
E allora cosa prova quando il suo nome viene inserito tra i sospetti casi di doping? «Non me ne importa nulla di liste nere o quant’altro. So chi sono e cosa ho fatto. Quello che è successo a me non c’entra assolutamente con il doping. E poi di cosa pensano gli altri non mi interessa. Sono i miei figli il mio unico punto di riferimento».
E magari anche i suoi assistiti visto che da qualche tempo svolge l’attività di procuratore. «Curo tanti giovani calciatori, tra cui Zigoni che è appena passato al Milan. A loro cerco di dare consigli. Credo di poterlo fare visto tutto quello che ho vissuto da calciatore. Non mi sono fatto mancare nulla».
Curiosamente il cerchio si è aperto e chiuso con il Bologna come avversario. «È vero, ma, se pennette, delle due partite ricordo con più piacere la prima» (ride).
2 novembre 1975, Lazio-Bologna 1-1: è il suo esordio in A. «Un’emozione unica, la più forte in assoluto. All’Olimpico, di fronte alla mia gente. Dovevo ancora compiere 19 anni. Merito dell’allenatore. Ebbe un gran coraggio. Mi dette il numero 4 e mi mise a fare il libero al posto di capitan Wilson. Un battesimo di fuoco niente male se pensa che quella squadra nel 1974 aveva vinto il campionato».
E intanto continuava a giocare con la Primavera dando spettacolo. «Alla fine vincemmo lo scudetto battendo in finale la Juve. All’andata fu un clamoroso 4-1, davanti a 25mila spettatori. Squadra fortissima, allenata da Paolo Carosi, un grande. Con me c’erano Agostinelli, Ceccarelli, Di Chiara, De Stefanis e un certo Bruno Giordano».
Il suo gemello di un tempo. Oggi come siete messi? «Sono state scritte e dette un sacco di fesserie su di noi. Da ragazzi eravamo inseparabili. Poi i rapporti si sono un po’ diluiti, anche per alcune incomprensioni. D’altronde si cresce, cambiano le esigenze, ci sono le famiglie. Quello che conta è che l’amicizia resista ancora oggi. Ognuno di noi sa che l’altro c’è».
A proposito, c’era anche lui quel 30 novembre: suo avversario con la maglia del Bologna. «È il destino. È stato uno dei primi a correre verso di me. Una coincidenza che dice tutto. Con Bruno abbiamo fatto tutto insieme, nel bene e nel male».
Comprese le scommesse clandestine? «Ma è una storia di trent’anni fa!».
Fa ancora male? «È stato un incidente di percorso. Frequentazioni sbagliate, personaggi discutibili. Come tanti miei compagni della Lazio, anch’io andavo al ristorante di Alvaro Trinca. Sono finito anch’io nella rete, senza grandi responsabilità. Non ho mai scommesso sui risultati della mia squadra, per esempio. Ma la mia difesa è servita a poco: mi sono beccato una lunga squalifica. Questo è quello che conta».
Come ha reagito? «Mi sono fatto forza, ho tirato fuori la grinta, la rabbia, la determinazione. Da storie come queste se ne esce da soli. Mi sono rimesso a studiare e mi sono laureato in Legge: avevo un debito con i miei genitori che così ho saldato. E poi ho iniziato a contare i giorni che rimanevano per il ritorno».
11 luglio 1982: l’Italia vince il Mondiale e l’amnistia la rimette in gioco con un anno e mezzo di anticipo. «È così. E pensare che in quella Nazionale potevo giocarci tranquillamente anch’io se solo fossi stato un po’ meno impulsivo».
Si riferisce al litigio con Bearzot in Argentina quattro anni prima? «Sì. Un errore che non rifarei. Avevo esordito a ventun anni, all’Olimpico, contro il Lussemburgo. Altra giornata da brividi per me. Libero della Nazionale, davanti a Zoff. Bearzot mi provò un altro paio di volte e poi mi convocò per i Mondiali d’Argentina. Per un ragazzo poteva essere già un grande premio, ma io in quel momento non la vedevo così».
Cosa successe a Baires? «Una cosa normale: Bellugi si fa male e Bearzot fa entrare Cuccureddu. Credevo toccasse a me, ero il sostituto di ruolo. Mi arrabbiai molto. Affrontai il mister a muso duro. Gli dissi che non ero lì per fare il turista e di non convocarmi in futuro se pensava di non farmi giocare. Il guaio è che lui mi prese in parola. Feci giusto un’altra partita a settembre e poi addio Nazionale. A ventidue anni».
E il treno azzurro non è più passato. «Incredibile, ma vero. Ho perso tutte le coincidenze possibili. Nel 1982 ero squalificato, quattro anni dopo, nonostante lo scudetto con la Juve e la campagna di stampa in mio favore, rimasi a casa: Bearzot è un friulano, non aveva certo dimenticato il mio gesto. Rimaneva Italia ‘90, ma mi hanno fermato prima».
La Nazionale è il rimpianto più grande? «Sì. Insieme al rifiuto alla Juventus nel l976».
– La spaventava Torino? «Di sicuro a Roma stavo da re, coccolato e amato. Mi voleva l’Avvocato in persona, parlai con Boniperti, ma alla fine decisi per il no. È stato un grande errore. Fossi andato alla Juve, non solo avrei vinto molto di più, ma non sarei stato fuori dalla Nazionale, non avrei perso due ami per le scommesse e avrei vissuto con meno stress».
Il matrimonio bianconero, comunque, poi c’è stato. «Nove anni dopo, meglio tardi che mai. A dire il vero la Juventus mi ha sempre cercato, anche dopo la squalifica. Abbiamo chiuso nel 1985, quando mi ero già trasformato in centrocampista».
Da stopper a mediano, una mutazione non comune. «Devo tutto a madre natura. Sono sempre stato un eclettico, capace di sapersi adattare ai ruoli. Tecnicamente non ero male, il temperamento non è mai mancato. Anche Trapattoni mi vedeva a centrocampo».
C’era un certo Tardelli da sostituire. «Ma non ne ho mai sentito il peso. Piuttosto c’era da giocare con Michel Platini, un mostro di bravura e di simpatia. La sera del Bernabéu, quando annullarono il mio gol (validissimo) del pareggio, mi disse: “Ha fatto bene l’arbitro a fischiare: se tu avessi segnato al Real Madrid, sarebbe finito il calcio”».
Perciò hai sbagliato uno dei rigori al ritorno? (sorride). «Erano spariti tutti. Al momento di individuare i rigoristi, non rimase nessuno. Andai anch’io sul dischetto, con Brio e Favero. Ma dagli undici metri sono sempre stato debole. Non riuscivo a mantenere la freddezza necessaria. Peccato, perché così uscimmo dalla Coppa Campioni. Ci tenevo moltissimo ad arrivare fino in fondo, per me era la prima volta».
Credo che il suo bilancio in bianconero sia comunque in attivo. «Certamente Scudetto il primo anno con una squadra rivoluzionata. Nel mezzo della stagione la Coppa Intercontinentale a Tokyo. L’anno dopo segnai sette gol, miglior cannoniere dietro Aldo Serena, con Marchesi che ricordo ancora come uno dei migliori allenatori che ho avuto. L’unico rammarico è stata la mancata riconferma nel 1987».
Per colpa di chi? «Principalmente mia. Boniperti, in realtà, mi aveva offerto un altro anno di contratto. Io volevo un accordo pluriennale. Credevo di meritarlo dopo due stagioni ad alto livello. Me ne sono andato via per orgoglio. Ma credo di non aver fatto la cosa giusta».
Lasciando la Juve o andando alla Roma? «Tutte e due le cose, anche se alla fine la decisione di giocare per la Roma potevo comunque risparmiarmela. Avevo tutti contro: i tifosi laziali mi consideravano un traditore. Quelli giallorossi mi vedevano come il fumo negli occhi per il mio passato alla Lazio e alla Juventus. È stata durissima, ogni giorno c’erano cori e insulti per me. Uno stress indescrivibile. Mi avevano persino detto di non azzardarmi a esultare sotto la curva in caso di gol».
Cosa che stava per accadere, vero? «Giocavamo in casa contro l’Inter. Dopo un quarto d’ora segnai il gol del pareggio. Colpo di testa e Zenga battuto. Allora, dall’euforia, presi a correre verso gli spalti. Nella concitazione del momento, non mi ero reso conto che stavo andando proprio sotto la curva Sud. In un attimo, misi la retromarcia e tornai indietro. Ma questa, sinceramente, non era vita».

Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
Editore: TMW NETWORK s.r.l. - P.I. 02210300519
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26208
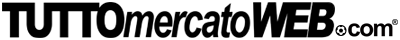
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus F.C. S.p.A.














