Gli eroi in bianconero: Carlo PAROLA
 TuttoJuve.com
TuttoJuve.comLa sua consacrazione definitiva avvenne quando la famiglia Panini decise di utilizzare una fotografia di Carletto che effettua in perfetto stile una rovesciata, come simbolo del proprio album di figurine. Per tutti i bambini italiani, Parola diventò quello della rovesciata.
«In bicicletta andavo veramente forte in salita, peccato che non fossi altrettanto bravo in discesa. Ma a rendermi prudente era stata una brutta caduta, piombando a valle da Pino Torinese, con serie conseguenze, la frattura di un braccio. Fu il calcio che spuntò nei miei orizzonti qualche anno dopo la morte di mio padre. Abitavo a Cuneo, dove non c’era il Velodromo, ma dove esisteva il campo sportivo: e fu là che presi confidenza con la sfera di cuoio e mi convertii a quello che giudico ancora oggi il più bel gioco del mondo.
Quando tornai a Torino, insieme ad alcuni amici appassionati, fondai una squadretta che, dal nome del corso adiacente al prato sul quale si giocava, venne chiamata Brianza. Avevo appena 10 anni ma ricordo che in quella compagine feci di tutto, dal difensore al centravanti, dal mediano all’ala e persino il portiere. La nostra squadretta non tardò a farsi un proprio nome ed ebbe anche i suoi tifosi che, domenicalmente, la seguivano, spingendosi in audaci trasferte magari fino a Porta Susa.
A quei tempi ero iscritto alla scuola allievi Fiat. Lavoravo, studiavo e giocavo a calcio, naturalmente, nella squadra ragazzi del Fiat: ero centravanti, segnavo moltissimi goal. Gli osservatori della Juventus mi seguivano con interesse e quell’anno su indicazione di Zambelli finii nelle file del club che sognavo giorno e notte. Portavo a casa 18 lire al mese: pensate quando andarono da mia madre e le chiesero se mi avrebbe lasciato giocare per 750 lire al mese! Mi guardò e mi chiese: “Ma è proprio vero?”.
Seppi più tardi che ero costato alla Juventus qualcosa come 60.000 lire, una bella cifra indubbiamente. Mi misi al lavoro con tutto l’entusiasmo possibile, avevo 18 anni e una gran voglia di sfondare. Mi cambiarono subito di ruolo: da centravanti passai dalla parte opposta, cioè nel ruolo di chi controllava i goleador. Forse fu anche per questo che affrontai sempre gli ex colleghi con una certa attenzione. Tremavo al pensiero che un giorno avrei potuto sostituire un certo Monti, io che avevo 18 anni e che davo del “voi” ai Foni, ai Rava e ai Gabetto. Un giorno accadde: esordii nella Juventus, in serie A. Proprio contro la mia attuale squadra, il Novara; vincemmo per 1-0 e fu una giornata bellissima, indimenticabile, io, ragazzino, in mezzo a tanti campioni! Come stopper metodista, mi difesi abbastanza bene e in seguito presi sempre più confidenza con il mio ruolo fino a impormi come titolare.
Passare dai ragazzi Fiat alla grande Juventus fu una cosa meravigliosa: penso che per ogni giocatore sia la stessa cosa, anche se sovente l’esordio è talmente infarcito di emozioni che si finisce con il perdere il senso della realtà. Fu 10 anni dopo che vincemmo lo scudetto, subito dopo la scomparsa del Grande Torino. Noi continuammo la tradizione che voleva il titolo appannaggio dei club torinesi. Fu una stagione meravigliosa: pensate che segnammo la bellezza di 100 goal. Il presidentissimo Agnelli aveva acquistato Martino, Hansen, Præst e altri campioni, avevamo Carver come allenatore. Il suo italiano era ancora incomprensibile per cui la tattica nasceva in campo a seconda delle necessità.
Fu allora che inventammo il libero anche se pochi se ne accorsero. Senza che lo stesso Carver se ne accorgesse, Karl Hansen fungeva da mediano, Mari si piazzava sul centravanti avversario ed io stavo in ultima battuta alle sue spalle, proprio come succede al giorno d’oggi. Allora però non si parlava tanto di tattiche: si giocava, si pensava a segnare il maggior numero possibile di goal e a subirne il meno possibile. Con questo non è che rinunciassimo ad attaccare anzi lo facevamo con 4 punte. Era il nostro gioco elastico a centrocampo a permetterci queste possibilità, tattica alla quale si richiamano anche oggi molte società.
Avevamo grandi avversari, come il Milan del trio Gre-No-Li, eppure vincemmo in bellezza. Parlando di quella formazione con Boniperti, concordammo in una giornata dedicata ai ricordi, che quella forse fu la formazione più completa del dopoguerra. Vincemmo il campionato con diversi punti di vantaggio. Era la mia decima stagione nella Juventus (complessivamente ho giocato in bianconero 15 campionati) la più bella, indubbiamente; anche lo scudetto successivo non fu così ricco di soddisfazioni».
SERGIO DI BATTISTA, DA “LA STORIA DELLA JUVENTUS” DI PERUCCA, ROMEO E COLOMBERO
Nel Louvre del calcio è immortalato il suo capolavoro: la rovesciata. È una delle immagini più famose nella iconografia del pallone, fissata per caso da un fotografo fiorentino che impellenti necessità avevano spinto nella trincea che una volta esisteva dietro le porte. La sagoma di Parola si staglia nella lieve foschia di una fredda domenica di sole. Sospeso nel vuoto, sorretto da invisibili fili, le braccia distese ad accompagnare, quasi a offrirlo alla platea, un gesto stilisticamente perfetto, la gamba sinistra piegata a sveltire il movimento, la destra tesa come una lancia: il pallone, colpito di pieno collo, vola via. Gli è vicino Egisto Pandolfini detto «motorino», che sta frenando la sua corsa, resa ormai vana dalla prodezza dell’avversario. Sullo sfondo si riconoscono il mediano Giacomo Mari e più indietro un altro attaccante della Fiorentina, il calvo Sperotto.
Era il gennaio del 1950. Parola aveva già 29 anni e stava per vincere il primo scudetto di una carriera non sempre pari alla classe, Della sua rovesciata si parlava ormai da un pezzo, da quando l’aveva esibita la prima volta a San Sito nella partita contro l’Austria, sotto gli occhi di giornalisti, tecnici, dirigenti accorsi da tutta Europa per vedere cosa restasse, dopo i disastri della guerra, dei campioni del mondo e della famosa scuola danubiana. Da allora quell’estroso esercizio acrobatico era diventato il suo grande numero, un colpo a effetto. «La sua battuta melodrammatica, il suo do di piede» scrisse Bruno Roghi. E lui, taciturno, quasi a schermirsi: «No, una disperata azione di salvataggio». Sarebbe comunque rimasta nella memoria dei gesti epici, come la sforbiciata di Caligaris, il gol a invito di Meazza, il passo doppio di Biavati.
Era un asso autentico, un vero «classico», uno dei maggiori prodotti in assoluto del nostro calcio. E stato per anni il giocatore più popolare della squadra più popolare d’Italia, il più famoso del mondo, con quelli del Grande Torino. Secondo maestro Brera – che lo vedeva troppo isolato in difesa – sarebbe stato un grandissimo centromediano metodista. «Si sentiva attaccante, dovette trasformarsi in difensore. Elegantissimo di stile, batteva pulito con i due piedi, aveva doti acrobatiche eccezionali. Non era un grande incontrista, non rischiava molto il tackle. I suoi diretti avversari segnavano un po’ troppo, questo sì».
Sentite Nordahl, che fu uno di quelli: «Giocare contro di lui era esaltante: non si poteva fare a meno di eguagliarlo in bravura». E un altro critico, Ettore Barra: «È il nostro più grande centromediano sistemista, il più grande d’Europa, ma al sistema è giunto senza entusiasmo. Avrebbe anche potuto essere il miglior centromediano metodista». Erano i tempi del grande dibattito tra metodo e sistema, delle infinite discussioni sulla fantasia di una tattica di gioco e sulla pragmatica disciplina dell’altra. Lui metteva tutti d’accordo. «I metodisti superstiti ringraziano Parola per non averli dimenticati» scriveva il poeta Roghi. «Talvolta evade, parte a lunghe falcate come se andasse a prendere una boccata d’aria, C’è sempre un calcolo nel suo gioco, nulla viene fatto a caso, in ogni azione di difesa c’è sempre urto spunto di iniziativa, un invito al compagno, una proposta». Non era l’uomo dei corpo a corpo, delle giornate tempestose, ma, si diceva, dell’estro, della manovra che supera l’avversario in prontezza e intelligenza.
La sua storici personale è, in un certo modo esemplare: da dipendente Fiat a campione d’Italia della Juve, non è capitato a molti nonostante i noti legami tra quella e questa. C’è poi qualche sfumatura in stile gozzaniano che non guasta, a uso degli agiografi. La perdita del padre quando è ancora un bambino, gli entusiasmi per il ciclismo e i motori (un giorno, già campione celebre, chiederà invano di partecipare alla Mille Miglia, al volante, come Ascari). Poi il trasferimento a Cuneo dove non c’è il velodromo e alla bicicletta è preferibile il pallone, i primi calci in periferia, la prima squadretta che fa accorrere ammiratori dai dintorni. Alla Fiat entra poco dopo aver finito le elementari, in tempi ancora lontani dalla scuola dell’obbligo.
Aiuto meccanico: il suo contributo, in quella famigliola mutilata dal destino, è un salario di 250 lire al mese. Fa parte della squadra dopolavoristica e in una partita di allenamento contro la Juventus gli capita di affrontare Borel. Deve cavarsela bene perché gli offrono di passare in bianconero e chi ne caldeggia l’acquisto è nientemeno che Caligaris. La trattativa non è così facile come potrebbe sembrare. Il presidente del Gruppo Sportivo Fiat è, per vocazione solo in apparenza contraddittoria, torinista e vorrebbe Parola in maglia granata. Risponde no. Deve intervenire, con una spicciativa telefonata, il giovane Gianni Agnelli.
Così Parola diventa l’anello ideale tra due epoche juventine. Arrivato pochi mesi dopo l’addio di Monti, ha tra i compagni Gabetto che lo informa sui segreti della rovesciata e poi, negli spogliatoi, gli regala due dita di brillantina; più tardi, già famoso, dovrà vedersela con un nuovo arrivato, un biondino di Barengo, tal Boniperti, che al primo allenamento gli farà un tunnel, ricambiato con un’entrata dura sulla caviglia perché impari subito, il ragazzino, a rispettare i grandi.
Giocò la prima partita in serie A sull’erba di casa, lui torinese, a Torino contro il Novara. Aveva come compagni di linea Depetrini e Varglien I, la Juventus vinse con un gol dell’altro Varglien. Sul giornale si lesse che il «giovane Pirola» aveva fatto un discreto debutto. Poi, nel commento del martedì un autorevole critico azzardò un giudizio più impegnativo scrivendo che «a dispetto di chi lo riteneva intempestivo, Caligaris ha mostrato una volta ancora di saper misurare i tempi: il debutto del giovane Parola è stato veramente confortevole e ha detto chiaramente come la Juventus stia preparando un nuovo, grande centromediano».
Diventò titolare due campionati più tardi al centro di un trio che vecchi tifosi ricordano – spesso capita alle formazioni del calcio – come una filastrocca infantile o il refrain di una canzone della gioventù, un’occasione di nostalgia: Depetrini, Parola, Locatelli. Con Parola il gioco della Juve aveva ritrovato una caratteristica che era tipica ai tempi di Monti: sapeva «servire lungo» e furono quei lanci e quei rifornimenti a permettere agli attaccanti di segnare tanti gol in una stagione che comunque non fu vittoriosa. A dominare la scena si era infatti presentata una nuova squadra: il Torino.
I campioni granata Parola li ebbe come avversari in campionato e come compagni in Nazionale, dove Vittorio Pozzo a volte gli preferiva Rigamonti, che aveva meno classe ma più grinta. Nacque l’idea che quel grandissimo «classico» non fosse altrettanto grande come incontrista, non amasse molto rischiare con il tackle, non fosse abbastanza «cattivo». Spesso le buscava. «Il limite di Parola – è l’opinione di Boniperti – era solo di una certa fragilità ossea, o forse di pura sfortuna, per cui l’avevo definito il Coppi del calcio». Di 10 partite in Nazionale la metà furono sconfitte, l’ultima – quella del mesto e precoce addio – in Brasile ai mondiali del 1950 quando la Svezia eliminò gli azzurri. Parola finì infortunato per un calcio di Jeppson. Con un altro centravanti svedese, Gunnar Nordahl, aveva avuto una brutta storia pochi mesi prima in campionato, una grigia domenica di febbraio. Quell’incredibile pomeriggio del 7 a 1 contro il Milan a Torino. I nervi a fior di pelle per lo straripare dei milanisti e la sfortuna degli juventini (proprio Parola aveva centrato un palo quando la squadra era in vantaggio), un’entrata scorretta, un calcio di ripicca: «Mi espulsi io, prima ancora che l’arbitro mi cacciasse». Commento di Gianni Agnelli che quel giorno soffriva in tribuna: «È l’unica cattiva azione di tutta la sua vita».
Questo era Parola, detto anche «Carletto l’europeo» per la più inutile, accademica ma anche famosa delle sue partite, quella del 1947 a Glasgow tra la Gran Bretagna e una rappresentativa che allineava incautamente le grandi stelle del calcio continentale. Era finita 6 a 1 per i britannici, due gol del centravanti Lawton, un autogol di Parola. Poi, al di là del risultato e delle apparenze, quei commenti che avrebbero celebrato una leggenda. «Ce Soir»: «Fortunatamente c’era Parola. Un Parola che ha fatto una partita straordinaria in condizioni delicatissime, in mezzo a una difesa quasi sempre scardinata e spremuta all’estremo. L’italiano sopportò validamente il confronto con i suoi più valenti avversari e ciò era più che una prodezza». Di analogo tenore i commenti dei giornali inglesi. Non poco per l’ex aiuto-meccanico del Gruppo Sportivo Fiat.
«Per me fu un grande onore e così penso, per il calcio italiano. Le altre nazioni europee indugiavano nel riprendere i contatti con noi: la guerra aveva lasciato il segno anche nello sport. I selezionatori mi videro all’opera a San Siro nella mia seconda prova in azzurro. L’11 novembre 1945 a Zurigo avevo esordito contro la Svizzera: il primo dicembre dell’anno successivo Pozzo mi confermò contro l’Austria che battemmo per 3-2. Io giocai abbastanza bene, feci una delle mie rovesciate, ma in quell’occasione ci fu una grandissima partita da parte di Maroso che avrebbe meritato di giocare nella selezione europea. Scelsero soltanto me cosi partii tutto solo per l’Olanda. Ci allenammo a Rotterdam, dove conobbi Wilkes, asso del calcio locale, e poi Nordahl, Præst e così via dicendo. Il 7 maggio giocammo a Glasgow in uno scenario indimenticabile. Gli stadi sudamericani dovevamo ancora scoprirli e quelli italiani erano piuttosto piccoli: Glasgow, invece, conteneva 150.000 spettatori, una cosa impressionante, cosi come restò indimenticabile quella partita contro i campioni britannici. Ricordo che nello stesso anno, la Juventus andò a giocare in Svezia contro una squadra di cui non ricordo il nome. Ricordo bene, invece, il nome di un’ala sinistra che ci fece impazzire: si chiamava Liedholm, era giovanissimo, due anni dopo sarebbe venuto in Italia assieme ad altri fuoriclasse del suo paese. “Però”, commentammo alla fine dell’incontro “quell’ala non stonerebbe in Italia”. Più avanti ci fu l’invasione straniera, arrivarono in tanti, anche per la Juventus. Nordahl fu ingaggiato dalla Juventus, se non che venne poi smistato al Milan in cambio di Pløger. Peccato, perché i nostri 2 scudetti potevano essere con lui almeno 5. Perché fu Nordahl successivamente ad indicare alla sua società i nomi di Liedholm e di Gren e a farli venire in Italia dopo avere constatato di persona che nel nostro paese si stava bene. Pensate se quei tre fossero finiti alla Juventus: un attacco composto da Boniperti, Gren, Nordahl, Liedholm e Præst avrebbe fatto almeno 150 goal!».
VLADIMIRO CAMINITI
Non esiste un altro, nella storia del calcio nostro, che emuli Parola nel suo modo di essere campione. È vero, c’era stato Rosetta, ma con Parola l’esercizio virtuoso diventa stile. Con Parola, il calcio parla al mondo, quel mondo di un’Italia ancora sbigottita se non disfatta che sgrana gli occhi su tutto, non ci sono più ideali, ogni valore è stato frantumato in un mare di sangue, ma si riaprono gli stadi e Parola esegue la sua rovesciata per tutti gli umili e diseredati, disegna l’illusione con la sua acrobazia meditata; la sua rovesciata, in Italia, contende alla pizza napoletana il primato della popolarità.
Parola nasce in una famiglia che è un grumo di ristrettezze. Torino non è solo piazza San Carlo, e i Savoia sono da tre anni in esilio, nel 1949, quando Parola è celebre. L’Italia è una Repubblica, Parola è l’alfiere di una Juventus che gioca un calcio stellare, non troppo istintivo, con un ragazzo biondo che abbaglia per i suoi goal freddi e poetici (Boniperti). Il papà di Carlo, detto Nuccio, è morto precocemente, vittima di un suo stesso vizio: si era accoppato ingurgitando tabacco pur di non andare soldato.
Il ragazzo si trovò presto a sostentare una famiglia. Al dopolavoro Fiat, sgobbava come garzone e nel tempo libero giocava a calcio, senza sapere che un singolare tipo di osservatore da qualche tempo, Parola aveva già 17 anni, veniva a osservarlo; l’orecchiuto compare Sandro Zambelli, detto Zambo, il cantore dell’altra Juventus, quello delle dame patronesse e dei signori in frac. Ora la Juventus, è il 1939, aspetta di ridarsi una verginità. Dopo la morte di Edoardo, gli Agnelli si sono messi da parte. Gianni è ragazzo. La presidenza viene affidata al conte dottor Emilio De La Forest de Divonne. Non si saprà mai nulla di questo patrizio. La storia dice che c’è la sua firma sul primo contratto di calciatore di Carlo Parola.
Parola nel campionato 1939-40 entra nei ranghi, è utilizzato in vari ruoli. Ha piedi morbidi e il suo calcio detta legge. Tanto è giovane, tanto è bravo. La guerra frenerà anche il suo cammino, ma è ancora in tempo per farsi amare. L’esordio è avvenuto contro il Novara, il 3 dicembre 1939, poi è tutta una scalata. Finisce la guerra, la ripresa è ilare e tormentata, a Zurigo l’11 novembre 1945 Parola è in campo contro la Svizzera, 4-4, non è un falco sul vecchio Amadò che segna 3 goal, non è proprio la sua giornata. Certi critici, secondo me maldestri, opinano che Parola non sia mai stato un combattente.
Non è esattamente così. Nelle sue tante partite in bianconero, nelle sue dieci presenze azzurre, Parola è sempre Parola, parla il calcio, vuole essere mai restrittivo, sempre evocativo di libertà. È il simbolo della libertà recuperata, non concepisce le strettezze di una marcatura assillante, in cui sono più bravi Rigamonti e Tognon. Ma nessuno lo vale per il gesto stilistico, per la capacità di giungere primo sulla traiettoria, annichilendo nei giorni di vena anche bisonte Nordahl sull’anticipo. Gioca nella Juventus fino al 1954, quando con John Hansen emigra nella Lazio.
E forse l’allenatore non è stato pari al giocatore, ma il mondo va così, e salendo sull’erta che ricorda quell’ameno sito che è Ceriale, con il suo mare strabiliante, Parola mi dava questa spiegazione del suo quasi fallimento come tecnico: «Sono stato un giocatore troppo grande per essere anche un allenatore troppo grande».

Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
Editore: TMW NETWORK s.r.l. - P.I. 02210300519
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26208
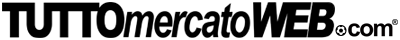
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus F.C. S.p.A.













