Gli eroi in bianconero: Bruno NICOLÈ
 TuttoJuve.com
TuttoJuve.comIn una caldissima domenica di giugno del 1957, la Juventus gioca allo stadio Appiani di Padova contro la formazione di casa. L’undici bianconero naviga a centro classifica, non bastano la classe di Boniperti, di Hamrin e di Corradi, la grinta di Garzena e Nay, la dedizione di Colombo e Montico per dare slancio e sostanza al gioco. La partita con il Padova si annuncia difficile. Nelle file della Juventus c’è anche Stivanello, che nel Padova aveva appunto giocato la stagione precedente, il quale avverte il compagno Nay: «Stai attento al ragazzino che gioca centravanti. Ha appena sedici anni ma possiede le doti del campione: uno scatto pazzesco e un tiro che non perdona!».
Aveva esordito qualche mese prima in Serie A: «È un sabato particolare: il giorno precedente il Paròn Rocco mi ha convocato per la partita casalinga con l’Inter, la sera guardo il Festival di Sanremo, ma in modo distratto, penso a cosa potrebbe succedere l’indomani. L’allenatore vuole aumentare il mio bagaglio di esperienza, vuol farmi sentire da vicino l’aria dello spogliatoio della Prima Squadra. Penso... Il mattino seguente è il 10 Febbraio 1957, mi sveglio e mi reco all’Appiani, luogo della convocazione, per la squadra è una domenica come le altre: Messa al Santo, pranzo da Cavalca e poi rientro all’Appiani a piedi. Entriamo negli spogliatoi e alle spalle sento la sua voce inconfondibile: “Bruno, cambiati che giochi!” Mi giro come a dire “Parla con me, Mister?” e con la sua faccia disincantata e prima che possa proferire parola, aggiunge: “Se te lo dicevo ieri, non te dormivi tutta la notte, saresti uno straccio in campo, invece mi servi al massimo. Fa queo che te te senti de far”».
Il primo tempo finisce 0-0; ma all’inizio della ripresa il ragazzino, di nome Bruno Nicolè, riceve un preciso lancio di Rosa, lascia sul posto Nay, aggira Garzena e fulmina il portiere Romano con un tiro imprendibile. Sullo slancio del vantaggio conquistato il Padova raddoppia con Bonistalli, poi Colombo riduce le distanze e finisce 2-1. Nicolè è un costante pericolo, sarà il migliore in campo. In tribuna ci sono alcuni dirigenti juventini, Nicolè è sotto osservazione; ma più di ogni cosa vale il giudizio espresso da Boniperti che, essendo in campo, ha visto da vicino le prodezze del robusto campione di Padova.
Nel campionato 1957-58, la Juventus rimette in piedi lo squadrone in grado di puntare al titolo. In prima linea ci sono Boniperti, il gallese Charles e l’argentino Omar Sivori; all’ala sinistra è confermato Stivanello, manca un uomo per fare una linea di attacco senza rivali: Bruno Nicolè. È abituato a giocare di punta, ma nelle prime tre giornate di quel campionato viene mandato in campo con la maglia numero otto. Boniperti, per lui la cosa non è nuova, gioca con il numero sette. Dalla quarta domenica, incontro di Ferrara contro la Spal, Nicolè è schierato all’ala destra, con Boniperti interno, regista di lusso per una squadra di lusso e le cose funzionano a meraviglia.
Bruno, però, è costretto a cambiare totalmente il proprio gioco: a Padova era la punta di diamante dell’attacco biancoscudato, a Torino c’è Charles e, in aggiunta, c’è anche Sivori; gli altri organizzano il gioco per i due strepitosi uomini goal. Nicolè, per il momento, mantiene tutte le belle promesse. Non è il primo talento che arriva da Padova per vestire la maglia bianconera, ventisette anni prima era stato acquistato Nane Vecchina.
Nella prima stagione juventina, disputa ventuno partite, ma non riesce ad andare in goal neppure una volta, mostrando cose da autentico campione e azioni che solo gli assi del pallone riescono a realizzare, ma perdendosi, talvolta, in indefinibili incertezze; l’età del ragazzo impone una verifica delle sue doti e naturalmente Bruno è riconfermato.
Per dare impulso alla sua personalità ancora acerba, si decide di riportarlo nel suo ruolo naturale, quello di centravanti; gioca, infatti, una splendida partita nella terza di campionato, a Padova su quel terreno dell’Appiani, dove era cresciuto e maturato come calciatore di rango. La Juventus vince per 4-1 e Bruno riceve tanti consensi, anche se, ancora una volta, manca l’appuntamento con il goal. Il 12 ottobre 1958, contro il Napoli a Torino, riesce a battere Bugatti e a realizzare il suo primo goal con la maglia bianconera, poi Sivori siglerà il 2-0 per la Juventus. Niente goal a Roma (contro i giallorossi che vincono alla grande per 3-0), poi il ritorno al successo personale nel derby, che la Juventus si aggiudica con l’insolito punteggio di 4-3. Ancora un goal a Firenze (3-3) e un altro a San Siro contro l’Inter (vittoria per 3-1 dei bianconeri). Il giorno di maggior gloria è, però, quello in cui Nicolè firma tutte e tre le reti con le quali la Juventus supera la Triestina allo stadio di Valmaura l’11 gennaio 1959. Ma anche la doppietta contro la Lazio (battuta per 6-2) merita una buona dose di applausi. Una stagione, tutto sommato, davvero lusinghiera per il diciannovenne giocatore della Juventus: ventuno partite giocate, tredici reti realizzate.
Sostanzialmente positivo il rendimento del giocatore nella stagione 1959-60, conclusa con il secondo scudetto: trentuno partite disputate e undici goal segnati. La Juventus ha ripresentato una prima linea molto efficiente e spettacolare: Nicolè, Boniperti, Charles, Sivori e Stacchini. L’argentino, che aveva Bruno in gran simpatia, mette a segno la bellezza di ventisette reti, Charles ne segna ventitré, Stacchini otto. Quella è una grande Signora: tanto è vero che nel 1960-61 concede il bis dello scudetto e ripresenta un Nicolè sicuro e pimpante: ventinove gare giocate, tredici reti segnate. Nella stagione 1961-62 disputa ben ventisette partite e realizza ancora settantotto reti, ma il suo rendimento lascia più di una volta a desiderare. L’ultimo campionato juventino per il ragazzo di Padova è il 1962-63: solo dodici gare e un solo goal segnato; oramai la parabola ascendente si è bruscamente e inesorabilmente arrestata.
Bruno è stato un buon giocatore, ha anche avuto la soddisfazione di conquistare otto gettoni nella Nazionale, con la quale ha esordito a diciotto anni, nel novembre del 1958 al Parco dei Principi, in un’amichevole con la Francia finita 2-2, le due reti azzurre portano la firma della giovane punta juventina.
Ha vinto tre scudetti con la maglia bianconera, due successi in Coppa Italia: ma non è bastato a far brillare in modo indelebile la stella del ragazzino di Padova. Abbandonato il calcio, dopo aver militato in altre squadre, a soli ventisette anni, Bruno Nicolè, diventa insegnante di educazione fisica.
CARMEN CALZA, DA “HURRÀ JUVENTUS” DEL GENNAIO 1968
Bruno Nicolè: uno dei casi più clamorosi del calcio bianconero e nazionale. Osannato e calpestato, idolatrato e vilipeso. Si può veramente dire che la sua carriera è stata un’altalena continua dagli altari alla polvere e viceversa. Una carriera lampo culminata nel ritiro dall’attività a soli ventisette anni. Oggi che Bruno Nicolè è un ex (ma fa un po’ ridere, però, questo termine che evoca tempie grigie, mezza età e via di seguito), che ha chiuso alle sue spalle la porta dorata del calcio, abbiamo voluto tentare un esame del suo caso, lo stesso, in fondo, di migliaia di giovani che ogni anno si affacciano a quella porta dorata e sognano la gloria sportiva.
Siamo andati a trovarlo nella sua casa dì Vicenza. Ha moglie, la graziosa signora Annamaria, e figlio, un pupetto bellissimo di quindici mesi, Fabio. È molto ingrassato, ha l’aria tranquilla, distesa, del borghese in vacanza. Nicolè, è la prima volta, credo, nella storia del calcio, che si parla di un ex di ventisette anni. Di un ex che conta, cioè. Che cos’è che l’ha indotta ad abbandonare l’attività così presto? «Il peso è stato sempre la mia croce. Ultimamente non ce la facevo più a tenermi sul peso giusto e quindi il mio rendimento non era normale. Ma questa è solo una delle ragioni, anche se piuttosto importante. In realtà avrei smesso già due anni prima, a venticinque anni cioè, quando mi trasferirono all’Alessandria. Non volevo giocare in Serie B; non che lo considerassi un disonore, ma non ho mai pensato di poter vivacchiare nel calcio. Forse perché sono partito molto forte non mi sono mai fatto eccessive illusioni. Cioè ho sempre saputo che dovevo considerare il calcio veramente un gioco e che presto o tardi sarebbe finito. La carriera di calciatore è un’incognita enorme, non ci si può fare un affidamento assoluto. Io giocavo, perché mi piaceva giocare ma non ne ho mai fatto una ragione di vita. Per questo ora non ho assolutamente rimpianti: è stato un periodo molto bello, potrei dire anche meraviglioso, ma è finito e ora ho altri traguardi. Oltretutto, nel mio caso, non so come avrei potuto continuare, con il gioco che si pratica adesso. Il calcio atletico presuppone doti di velocità, di ritmo e quindi di condizione atletica sempre perfetta che per me sarebbe stata troppo difficile non solo da trovare ma soprattutto da mantenere. Il mio fisico purtroppo è tutto particolare: il minimo incidente che mi costringeva a un giorno di riposo si trasformava in una vera e propria tragedia; perché stare fermo un giorno voleva dire aumentare due chili. Quindi mi ci voleva poi un superlavoro per ritornare in peso e, di conseguenza, non ero mai a posto. Per questo, due anni fa, ero già pronto per l’abbandono. Ho poi accettato il trasferimento all’Alessandria, perché dovevo ancora fare il servizio militare e altro è farlo nella compagnia atleti, piuttosto che al CAR comune, soprattutto con la famiglia già formata».
Che cosa prova un ragazzo che tra i sedici e i diciotto anni si trova a passare dalla Serie B alla squadra Campione e alla Nazionale? «Io credo di non essermi mai montato la testa (la signora Annamaria scuote la testa con aria dubbiosa: lei è di parere contrario); forse a un certo punto mi sono un poco rilassato, la conquista era stata fin troppo facile. Ma penso sia comprensibile: a quell’età non si può avere l’equilibrio psichico che dà la maturità. Devo dire anche, però, che questa celebrità improvvisa mi ha creato un mucchio di problemi e che tutto sommato sarebbe stato preferibile arrivare per gradi, senza sprazzi. Io, con tutti i miei alti e bassi, posso comunque dire di essere stato ancora fortunato. Forse proprio per lo spirito con il quale ho sempre preso tutta la faccenda ho potuto, a un certo punto, valutare il pro e il contro e prendere una decisione. Ci sono molti (la maggior parte, penso) che invece non si sanno vedere al di fuori del calcio e le assicuro che in questi casi è molto brutta la fine della carriera. L’inserimento nella vita delle persone, diciamo così, normali è difficilissimo e purtroppo non tutti pensano in tempo a quello che faranno quando non saranno più gli “idoletti” della domenica».
Quali pensa siano state le cause che le hanno fatto mancare il vertice stabile della carriera? «Non lo so, è difficile dirlo coni sicurezza. È azzardato anche dire che avevo in partenza le possibilità di diventare un grande del calcio. Può anche darsi che mi abbiano sopravvalutato, è un ambiente nel quale si perde facilmente il senso delle proporzioni e si riesce anche facilmente a farlo perdere. Un ragazzo fa presto a esaltarsi a sentirsi dire sempre che è bravissimo, può darsi che io abbia commesso degli errori di natura psicologica, come può darsi che le ragioni siano di carattere esclusivamente tecnico. Comunque, in quei tempi, si poteva pensare che avesse ragione chi mi esaltava; adesso, visto come sono andate le cose, si direbbe che abbia avuto torto».
Quando ha cambiato squadra non ha pensato che poteva essere per lei un’occasione per ricominciare tutto da capo? «Sì, in effetti, il primo anno, nel Mantova, sono andato piuttosto bene. Sono anche tornato in Nazionale quell’anno e credo di aver fatto un campionato positivo. Poi sono andato alla Roma e lì sono rimasto coinvolto nella situazione sballata in cui è venuta a trovarsi la società. Ricorderà la baraonda che c’era, le collette dei tifosi e altre cosette amene. Così il campionato è stato quel che è stato, alla fine hanno ceduto i pezzi più commerciabili e così io sono andato alla Sampdoria. Lì mi trovavo benissimo, ero partito proprio bene, il signor Bernardini era contento; poi una bella mattina, in novembre, vado in sede e leggo tra le comunicazioni affisse all’albo che sono trasferito all’Alessandria. Nessuno mi aveva parlato di trasferimenti, ero lontanissimo da un’idea del genere. Così è maturato il proposito di finirla con il calcio. Ho fatto subito i miei programmi: finire gli studi, prima di tutto. Ho sempre dovuto rimandarli; gli allenamenti, i ritiri non incoraggiano certo a studiare. Ora ho altre soddisfazioni, non economiche ma d’altro genere».
Che cosa consiglierebbe a un giovane che vedesse partire con le sue stesse possibilità, con le premesse che aveva lei dieci anni fa? «Quello che ho detto prima: non perdere mai il senso delle proporzioni e tener presente che nella vita ci sono altri valori. L’ambiente del calcio da un’educazione sbagliata, anzi è impostato in maniera sbagliata. Il giocatore è una macchina, fin che va è tutto bello, quando si guasta nessuno pensa a lui. Per questo bisogna partire con le idee chiare, prendere la professione seriamente sì, ma essere preparati anche al momento in cui finisce, un momento che può arrivare da un istante all’altro. Fin che sono in attività i giocatori sono coccolati, viziati, si sentono al centro dell’universo, trovano un mucchio di persone che risolvono i loro problemi. E quando si trovano a dover affrontare da soli nuove responsabilità non ce la fanno. È un mondo irreale che per un ragazzo può diventare molto pericoloso se non ha sufficiente forza di carattere. Quindi un consiglio che si può dare, prima di tutto, è di mettersi le spalle al sicuro con un titolo di studio, anche se costa sacrificio. Dopo è più facile sistemarsi e inserirsi in una nuova vita».
Se per magia ritornasse, in questo momento, ad avere sedici anni, al punto di partenza della sua carriera, quali sono le cose che rifarebbe e quali quelle che eviterebbe? «Non è possibile dirlo. L’esperienza la si fa al momento, sul posto e nelle precise circostanze. L’esperienza degli altri non serve a nessuno, e nemmeno la propria se si riferisce a fatti di dieci anni prima. Se io tornassi ad avere adesso sedici anni probabilmente rifarei tutto da capo, visto che ho sempre fatto tutto in buonissima fede e senza barare. È andata così, non posso dire altro. La mia esperienza di calciatore, semmai, se lui vorrà, la userò per insegnare a mio figlio, a lui solo».
Prende il braccio del piccolo Fabio, se lo guarda con un sorriso pieno d’amore paterno e di orgoglio paterno. «Le dico la verità, questo è il più bel traguardo che ho raggiunto, più bello ancora dei famosi due goal in Nazionale a Parigi».
ANDREA NOCINI, DA PIANETA-CALCIO.IT DEL 14 FEBBRAIO 2010
Così il sommo Gianni Brera salutò il debutto con tanto di doppietta in azzurro dell’ancora diciottenne “torello” ragazzino di Padova, già da un anno in forza alla Juventus di Giampiero Boniperti: «Parigi, 9 novembre 1958, stadio Le Colombes, amichevole tra i “cugini” transalpini e l’Italia del Commissario Tecnico Gipo Viani: i “blu” passano al 15’ con Vincent, ma c’è l’imberbe nove azzurro che, dopo la pausa del thè, compie due possenti capriole e tratteggia due goal che lo consegnano per sempre alla storia. Non è colpaccio italiano (pareggia Fontaine all’84’), ma è autentico trionfo per il ragazzotto lanciato nel ribollente catino del magico Silvio Appiani da Nereo Rocco nel suo Padova dei “manzi”».
Il parallelo con il maestro della rovesciata, Silvio Piola, tessuto dal grande vate del giornalismo sportivo italiano, Gianni Brera, forse non è poi così irriverente. Una carriera, quella di Bruno Nicolè, sparata come fuori da un cannone carico di promesse e coriandoli ma durata lo spazio quasi di un mattino, di un breve, intensissimo quarto d’ora di felicità. Tre scudetti e due Coppe Italia con la “Vecchia Signora”, poi, la Roma, la Sampdoria, il Mantova, e l’addio al calcio a soli ventisette anni. Per salire in cattedra nelle scuole a insegnare Educazione Fisica fino alla pensione, e suggerire educazione civica come umile ma acuto corrispondente e collaboratore di giornali della sua Azzano X, nel Pordenonese, dove oramai vive definitivamente con la sua famiglia.
In quella cittadina friulana che chiama “Oasi della natura”, che riesce ancora a commuoverlo per gli splendidi scenari di fauna e flora che offrono all’uomo attento (non distratto dal chiasso delle grandi metropoli) incomparabili scenari, sanguigni sfondi caravaggeschi.
Un addio, il suo, che ancora oggi rimane avvolto dal suo silenzio e ammantato dal passato, che contribuisce sempre a mitizzare tutto. Anche le sofferenze più indicibili, i rimpianti più struggenti. Non soprannominatelo, per carità, meteora del calcio italico, perché lui vi risponderà tra il troppo sicuro e l’infastidito, picche, con quella serenità anche di chi sembra aver rimosso subito (e da una vita) quella grande escalation contrassegnata poco dopo da una ripida, altrettanto supersonica discesa nel dimenticatoio.
Ma, non certo nella mente e nel cuore di chi ama le favole, i grandi racconti del pallone, le storie di uomini vere e di mostri sacri del più bello e pulito calcio del nostro Belpaese. Quello che si ricorda sempre volentieri, e chi ti dà la forza di guardare al futuro, con la speranza di narrare, rivivere la storia di un altro nostro campione di umanità, prim’ancora che di tecnica. Di lealtà e di grande esempio, anche nell’uscire dalla scena luccicante della grande ribalta in punta di piedi, senza far sceneggiate, in silenzio, senza tante polemiche o alzate di scudi. Qual è stato il goal più bello della sua carriera, professore? «I goal sono tutti importanti e tutti belli: sia quelli più facili, che quelli più difficili».
Ecco, c’è un goal in trasferta in Coppa dei Campioni con la maglia della Juventus? «In Coppa dei Campioni, a quell’epoca che era l’inizio di quella competizione, erano poche le partite. Non come oggi. Diciamo che di goal ne ho fatti, però, la partita più importante, quella che ha lasciato in me la traccia più indelebile è stata nel 1962 contro il Real Madrid di Alfredo Di Stéfano, di Kopa, di Gento, di Puskás e Santamaría. Abbiamo vinto 0-1 al Santiago Bernabéu grazie al goal di Sivori. Poi, perdemmo 0-1 al Comunale di Torino e siamo stati costretti a disputare la bella a Parigi, soccombendo per 3-1 e non vedendo la finalissima. Era il Real Madrid che vinceva tutto e che aveva conquistato cinque trofei di seguito».
Lei ha giocato assieme a grandi campioni del calibro di Giampiero Boniperti, Omar Sivori, di John Charles, il Gigante Buono; conserva qualche aneddoto curioso? «Di aneddoti di questi grandi campioni ce ne sono parecchi. Hanno lasciato un insegnamento profondo in me quando diciassettenne giocavo a fianco di assi già affermati, già consacrati. Quello che mi hanno trasmesso è stata la loro grandezza di giocatori prima e di uomini fuori dal campo poi. Sono stati un forte esempio: bastava solo guardarli e imparavi».
Cos’è che le dà più fastidio e cosa la riesce ancora a commuovere nella vita di tutti i giorni? «L’incontro e il confronto umano riescono a darmi soddisfazione. Questo e i miracoli della natura. Io ho la fortuna di vivere ad Azzano X, una cittadina, in cui trionfa ancora in tutto il suo splendore la bellezza del creato».
Cosa invece la stizziscono maggiormente? «Senz’altro, la violenza, l’arroganza, la prepotenza, la maleducazione».
Pure l’ipocrisia? «In parte anche quella. Ma, la maschera della vita molti ce l’hanno, ma, purtroppo, l’ipocrisia fa parte del contesto in cui viviamo».
Autogoal, nel senso di rimpianti, rammarichi, ne esistono nella sua vita di uomo? «Rammarichi ci sono sempre in tutti i calciatori, in tutti gli uomini. Io ho cominciato presto, a sedici anni, e ho terminato presto, a ventisette. Ho svolto per dodici anni la carriera di professionista. Forse, avrei potuto farne qualcheduno in più, ma io ritengo che un calciatore quando dice basta sa benissimo il motivo che lo ha spinto a staccare la spina con il calcio giocato. Ho fatto altre scelte che mi hanno avvantaggiato. Non ho rimpianti, perché ho avuto la fortuna di crescere giovane nel mondo del calcio professionistico, dove cresci subito e dove ho vissuto tante emozioni. Ma, sono stato appagato anche nella vita professionale che mi ha accompagnato nel dopo calcio. Però, sono cresciuto di più, terminata la parentesi calcistica professionistica, che quando sono uscito da quel limbo dorato e ho dovuto fare i conti con la vita di tutti i giorni. C’è stato, alla fine, stilando una sorta di bilancio personale, un equilibrio tra quella parentesi e lo sport. Che era connaturato in me, era più congeniale alla mia natura. E, questa seconda caratteristica mi ha permesso di stare in mezzo ai giovani e di insegnare nelle scuole».
Come si immagina l’Aldilà quando la palla avrà varcato la fatidica linea bianca della porta (terrestre) e della vita? Quali giocatori vorrebbe rivedere, riabbracciare? «Beh, sono tanti i giocatori che vorrei riabbracciare sia nelle mie squadre di appartenenza, ma direi tutti quelli con cui ho giocato assieme e che ora non ci sono più. Ci sono dei giocatori che mi hanno lasciato tracce profonde in me, come Charles, Sivori, quelli del Padova, che hanno fatto di tutto per aiutarmi in campo, considerato che ero un giovane che si affacciava alla Serie A a soli sedici anni. Ricordo con tanto affetto l’argentino Rosa, Scagnellato, Pin, Biason, Bonistalli, Zanon. Tutti i giocatori di quel mio Padova di forte e importante crescita calcistica».
E il Paròn? «Rocco era di un fascino grandioso, di un’umanità profonda, ha lasciato anche lui un segno in me. Un allenatore molto bravo, che sapeva fare gruppo, forte dell’esperienza di Nazionale e di calciatore della Triestina in Serie A. Il suo segreto è che riusciva a far rendere tutti quanti al meglio. Era anche un padre. Quando debuttai, mi parlò poco alla vigilia, per non traumatizzarmi. Mi disse solo “Bruno, fai solo quello che ti senti di fare!” Tutti i giocatori del Padova che hanno avuto la fortuna di passare sotto la sua guida, lo hanno sempre venerato, gli hanno sempre tributato grande affetto e riconoscenza. Uomo di campo, anche. È stato lui a lanciarmi. All’esordio avevo solo sedici anni. All’Appiani, contro l’Inter, abbiamo vinto 3-2 e mi ricordo ancora che in ritiro, non dicendomi allora niente, scambiai quella soluzione per un semplice viaggio di piacere. Invece, qualche minuto prima di scendere in campo mi disse: “Cambiati, che giochi!” Sapevo che quella sarebbe stata la partita fondamentale della mia vita, anche perché si vociferava di un mio interessamento da parte della Juventus, grazie a Stivanello, grande asso padovano passato alla “Vecchia Signora”; mi conosceva perché spesso veniva a vedere la partita di noi Riserve, di noi promesse biancoscudate, in cui avevo cominciato a quattordici anni. “Se sbaglio al mio esordio – commentavo tra me e me – poi è difficile riapparire”. E, invece, fortuna ha voluto che è stato l’inizio non di una lunghissima carriera, ma, di dodici anni di professionismo».
Un Padova, quello della stagione 1957-58 (terzo posto dopo Juventus e Fiorentina), che toccò la parabola più alta della storia del calcio patavino, detto dei “manzi” per la formidabile costituzione fisica di molti suoi atleti, e che dava puntualmente la paga alle grandi ogniqualvolta si recavano al Silvio Appiani. «Rocco non era di molte parole: lui dava delle indicazioni prima della partita, durante la settimana caricava al massimo i giocatori, in modo di metterli in condizione di esprimere il meglio di se stessi. Tutti i giocatori che sono passati dalle sue mani hanno sempre dato il meglio. Quando si battevano le grandi, lui diceva in dialetto: “Mi pensao prima della partia di ciaparne zinque. Inveze, emo vinto e non so se per gli influsi divini o del santo protetore Antonio, che fa i miracoli”. E, così contro l’Inter di Ghezzi, Skoglund, Lorenzi, il Milan di Pepe Schiaffino, del famoso GRENOLI, della Juve di Boniperti. A proposito di Nordahl, l’ho conosciuto alla Roma, e mi ricordo ancora della fotografia dell’ex pompiere milanista che mi mette la mano sulla spalla; quella fu per me, contro il Milan, la migliore partita del Padova e mia. Però, è stata (stranezze del calcio) l’unica partita, che abbiamo perso all’Appiani».
Dopo il debutto, alla quarta di andata, contro la Juventus, nel 1957, una gran bella soddisfazione, suggellata anche da un goal. «Esatto, ricordo ancora con piacere che è stata una gran bella partita, quella sfoderata dal Padova, ed è stata la prima volta che dal campo ho potuto conoscere da vicino quel Boniperti che avevo avuto occasione di vederlo da ragazzino sempre all’Appiani, quando la Juve venne a imporsi per 0-2. Con reti di Mari su rigore e di Martino, un argentino strepitoso».
Il 9 novembre 1958, a Parigi, il debutto con il doppio botto con la maglia azzurra, in Francia-Italia. «Quell’esordio da diciottenne è un record non ancora battuto: sono stato uno dei più giovani giocatori arrivato in Nazionale abbastanza presto. Aver segnato due goal, poi, per me ha rappresentato una gioia incredibile. Ricordo quella partita. In campo a uno poteva essere consentito di piangere dalla gioia».
I giocatori più forti affrontati in campo? «Di Stéfano del Real Madrid e Pelé. Contro il brasiliano ho giocato nel 1961 in Italia, nell’ambito di un quadrangolare contro il Santos, la Juventus e l’Inter. Sapevo che era un grande giocatore, ma, da vicino, in campo Pelé e Di Stéfano sono stati i due più grandi giocatori del mondo. In Italia, a quell’epoca, metto Rivera e Boniperti».
Di cosa è malato il calcio professionistico? «Di business troppo esasperato. È tronfio per i troppi soldi che circolano. E, poi, c’è troppa violenza negli stadi. Motivo per cui molti bambini e molte persone hanno abbandonato gli stadi. D’accordo la televisione e i diritti televisivi, ma la prima colpevole è stata la violenza. Un fatto che dovrebbe far riflettere tutti noi amanti di questo sport. In Inghilterra la violenza è stata risolta e si registrano stadi pieni, con tifosi che cantano invece di dare la caccia come facevano gli “hooligans” al tifoso avversario. Come mai c’è stata questa netta inversione di tendenza? In Italia bisogna chiedersi il perché di tutta questa violenza. A scuola, quando facevo delle riflessioni e abbiamo composto un libro sui mali del calcio e dello sport in generale, gli studenti rimarcavano quest’aspetto e dicevano: “Certo che per noi ragazzi vedere la violenza sia all’interno che fuori dello stadio non è educativa né questo è bello”. Quindi, conoscevo la risposta dei miei giovani: conservo ancora molti temi su questo argomento. Noi dobbiamo tutti chiederci cosa si deve fare per arginare questo dramma. E, ultimamente avete anche voi osservato che è una continua processione di bestemmie in campo, anche se i più furbi protagonisti cercano di coprirsi il labiale».
In campo attaccante, nella vita difensore? «Più difensore. E ciò mi ha dato il giusto equilibrio nel vedere, valutare e tornare ai giusti e veri valori sportivi. Questo mi ha trasmesso il calcio post professionistico. Ho, quindi, preso il meglio del calcio professionistico, che mi permette di vedere le cose, i fatti della vita con la giusta ottica, con la giusta lente».

Direttore: Claudio Zuliani
Responsabile testata: Francesco Cherchi
Editore: TMW NETWORK s.r.l. - P.I. 02210300519
Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26208
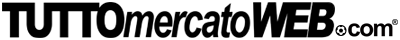
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a Juventus F.C. S.p.A.













