Gli eroi in bianconero: Roberto PEREYRA

Roberto Maximiliano Pereyra è una delle belle novità della stagione – scrive Paolo Rossi su “HJ Magazine” del gennaio 2015 – arrivato a Torino forte di un’importante esperienza nel nostro calcio, l’argentino sta dimostrando grande continuità di prestazioni e lo spirito di un ragazzo che conferma di avere buona personalità e non solo sul versante tecnico. Nella Juventus di un altro Massimiliano, mister Allegri, Pereyra rappresenta una sicurezza.
Hai un nome doppio e qualche soprannome. Come preferisci essere chiamato? «Mi chiamano Roberto, Robi, Max, Maxi, Tucumáno… Quello che mi piace di più è però Tucu, è un omaggio al posto dove sono nato, San Miguel de Tucumán, nel Nord dell’Argentina. È importante avere un segno delle proprie origini. Anche perché me li ricordo bene quei giorni nei quali ho scoperto l’amore per il calcio».
Ecco, il calcio. Dove hai imparato a giocare? «Io sono cresciuto a Mar del Plata, sull’Atlantico. Il calcio è sempre stato una passione di famiglia. Mio padre ne parla sempre, mio fratello più grande giocava e devo a lui molti consigli, mi accompagnava anche a fare gli allenamenti, mi ha dato un grande sostegno. E poi in casa eravamo tutti tifosi accesi del River Plate, ancora adesso se possiamo seguiamo le partite in TV, il tifo è qualcosa che non si cancella. Lo sa bene anche Tévez, lui ha giocato nel Boca e quindi, adesso, si può dire che dentro la Juve c’è un bel derby argentino: recentemente hanno perso loro, Carlitos mi deve offrire un bell’asado…».
Che giocatore eri nell’infanzia? «In Argentina si pratica il fútbol de potrero. Il calcio di strada, quello dei campi irregolari, con le pietre, l’erba spelacchiata. Giocavamo scalzi ma non ci interessava, quando vedi un pallone, non senti nulla e non guardi nient’altro. E impari tanto, tantissimo, senza filtri. Il dribbling, la furbizia, il coraggio nelle giocate e nei contrasti. È un calcio vivace, ti regala tanta esperienza in modo istintivo. Quando poi affronti il calcio vero ti sembra tutto più facile».
Avevi un modello a cui ispirarti? «Quello che mi ha suggerito mio padre, l’idolo di casa: Ariel Ortega. Lo abbiamo seguito anche quando ha giocato in Italia, nella Sampdoria».
E quando sei arrivato al River Plate? È stato il coronamento di un sogno? «È stata una grandissima soddisfazione. Io comunque sono portato a ragionare per obiettivi. Guai pensare che sei arrivato. Il River Plate è stato fondamentale, perché ho esordito in campionato a soli diciotto anni e per come mi ha testato in tanti ruoli diversi. All’epoca venivo utilizzato a sinistra, perché volevano che sfruttassi il destro quando facevo le finte a rientrare: se ci pensi è anche una difficoltà in più, ma è anche una possibilità per imparare qualcosa di nuovo. È anche grazie a quell’esperienza che ho capito quanto nel calcio di oggi sia fondamentale saperti disimpegnare in tanti ruoli. Io davanti li ho fatti quasi tutti: ala, trequartista, interno. A me piace attaccare, ma mi sono reso conto subito di quanto sia fondamentale impegnarsi nel riconquistare la palla e non essere egoista».
Sei arrivato molto giovane in Italia. «E prima di quanto pensassi. La Serie A era sempre presente nei miei pensieri, se fai questo mestiere non puoi che guardare con attenzione a un campionato così importante. Però non mi aspettavo di arrivarci così in fretta. Quando si è ventilata la possibilità non ho avuto esitazioni. Ne ho parlato in famiglia e siamo stati tutti d’accordo che rappresentava un’occasione decisiva per dare una svolta alla mia carriera».
Ci sono somiglianze tra il calcio italiano e quello del tuo paese? «In Italia c’è sicuramente un’attenzione tattica che in Sudamerica non esiste. Non solo per la cultura degli allenatori. È la mentalità dei tifosi che ti fa vivere la partita in un modo speciale, molto offensivo e anche individuale. In un campo argentino senti che la gente ti spinge in avanti, è soddisfatta solo se interpreti la partita come una battaglia».
Come ti sei trovato a Udine? «L’inizio non è stato facile. Sia chiaro: la città è perfetta, ti mette a tuo agio, ma io ho fatto un po’ di fatica ad ambientarmi. In più non giocavo tanto, perciò un po’ soffrivo. Però il mister Guidolin mi ha sempre tranquillizzato, confermandomi che avevo fatto la scelta giusta. E ho capito che tanto lavoro stava pagando quando ho fatto il mio esordio proprio in Scozia, in una partita di Champions League. Giocare nella manifestazione che guardavo in Argentina come una meta quasi inarrivabile. È stato indimenticabile. Tutto il resto è venuto dopo».
Del resto tu hai una storia particolare con gli esordi. «Sì, è vero. In Serie A la mia prima partita l’ho giocata allo Juventus Stadium. C’era la neve, quel giorno, un freddo pazzesco. Ho sostituito Isla e, sinceramente, non ci ho capito granché. Decisamente più serena è stata la mia prima da titolare con la Juventus, guarda caso contro l’Udinese. Mi ha fatto un piacere immenso giocare proprio contro i miei ex compagni, perché conosco bene quanta voglia ci mettano per affrontare la gara a Torino, è una sfida elettrizzante e per me è stato un po’ come chiudere il cerchio aperto con il mio arrivo in Italia».
Ma è davvero molto diverso giocare in una grande squadra come la Juve? «Se penso alle pressioni, devo dire che anche a Udine non mancavano. In Italia il calcio ti insegna subito ad assumerti le tue responsabilità, ogni gara è importante, c’è una forte attenzione mediatica, si analizza tutto. Ma quando sei in una squadra come la Juventus c’è qualcosa di particolare: il dovere di vincere sempre. È un pensiero fisso, a partire dalla settimana. Ogni energia viene spesa per questo obiettivo. Ed è meglio così. Perché giocare con grandi campioni ti rende le cose più facili. E a Torino ho capito che se stai attento a tutto (le giocate di Andrea, la grinta di Carlitos, gli insegnamenti del mister) ogni cosa può diventare possibile. Anche perché capisci subito che dopo tre scudetti nessuno è appagato, c’è una voglia di vincere che ti senti addosso».
Oltre alla Juve un’altra tua conquista del 2014 è stata la Nazionale. Sei entrato nell’Argentina vice Campione del Mondo. Che effetto ti fa? «In casa non ci credono ancora. Mi vedono giocare con Messi, Tévez, Agüero. Fantastico! Devo dire grazie alla Juventus e allo spazio che mi ha dato. Qui hai una visibilità che rappresenta una garanzia. È come se ci fosse una legge: se sei bravo nella Juve, lo sei anche per l’Argentina. Per questo sono stato convocato. Lo volevo fortemente, ma pensavo a tempi più lunghi».
Personalmente ti ho trovato già perfettamente calato nella parte in Milan-Juventus. Terza giornata di campionato, primo big match e grande partita. «Io non isolo nessun episodio particolare. È l’insieme del lavoro che mi sta piacendo. Vedere che quello che proviamo in allenamento funziona poi in partita, come affrontiamo le partite, come stiamo crescendo. Fare una bella prestazione è importante, ma non è un episodio che ti fa sentire un giocatore da Juve, devi dimostrarlo in ogni momento».
Perché hai scelto il numero trentasette sulla maglia? «Me lo diedero al River Plate, senza una specifica ragione. Da allora è diventato un portafortuna e tutti i miei amici mi dicono che non devo assolutamente cambiarlo».
Come ti prepari alle partite? «Sono un tipo molto tranquillo. Non ho particolari tensioni, semmai ho una gran desiderio che arrivi presto il momento della partita. In camera sono con Asamoah e ci alterniamo. Io gli presento la musica argentina che amo, lui quella africana. Si fanno delle belle scoperte, si conoscono pezzi nuovi. Poi, nell’imminenza della gara, mi carico con ritmi più accesi. Ho bisogno di ritmo. E poi via, fischio d’inizio e si gioca».
Come si evince da quest’intervista, si può dire che il primo anno in bianconero del Tucu è positivo. Allegri scopre il trequartista che cercava da sempre e un elemento che, subentrando a gara in corso, può spaccare la partita. Pereyra risponde con buone prestazioni, condite da goal importanti: come i due che segna al Verona nel giro di tre giorni (in Coppa Italia e in campionato), all’Empoli e alla Fiorentina (ancora campionato e nella fantastica rimonta in Coppa Italia) e, nel finale di stagione, al Napoli e ancora al Verona (con un meraviglioso tiro a giro). Gioca anche pochi minuti della sfortunata finale di Champions League, avendo sul piede l’occasione giusta per il meritato pareggio juventino. Ma ne esce un tiro debole e il pallone termina fra le braccia del portiere catalano, così come la coppa qualche minuto dopo. In totale, cinquantadue presenze e sei reti, uno scudetto e una Coppa Italia, un bottino per niente male.
La stagione successiva è un calvario: un infortunio alla coscia destra (con relativa ricaduta), lo tiene fermo per più di tre mesi. In più, dopo l’inizio stentato della Juventus, Allegri abbandona la difesa a quattro e il trequartista per il consolidato 3-5-2 e per il Tucu lo spazio si riduce notevolmente. Ne risentono anche le sue prestazioni, sicuramente al di sotto le proprie possibilità, Le presenze sono solamente sedici, i goal pari a zero e il suo contributo alle nuove vittorie è poco più che modesto. Cosicché, è ceduto al Watford poco prima della chiusura del mercato estivo.
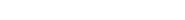

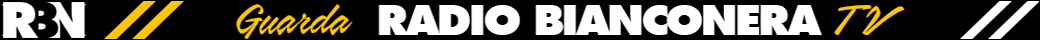



 Chiesa mi è sempre piaciuto. È un sanguigno, un combattente. Fa parte di quella categoria di giocatori che, quando scendono in campo, ci mettono sempre l’anima. Non si arrende mai, lotta per la maglia che indossa. E, per tutti questi motivi, lo considero...
Chiesa mi è sempre piaciuto. È un sanguigno, un combattente. Fa parte di quella categoria di giocatori che, quando scendono in campo, ci mettono sempre l’anima. Non si arrende mai, lotta per la maglia che indossa. E, per tutti questi motivi, lo considero...
 Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, c'è stato un contatto nelle scorse settimane tra Juve e Genoa per Albert Gudmundsson (26), che in Italia piace moltissimo anche a Inter e Roma. La richiesta si attesta sui 30/35mln, ma - come già...
Secondo indiscrezioni raccolte da Tuttojuve.com, c'è stato un contatto nelle scorse settimane tra Juve e Genoa per Albert Gudmundsson (26), che in Italia piace moltissimo anche a Inter e Roma. La richiesta si attesta sui 30/35mln, ma - come già...
 Tra due giorni bianconeri di nuovo in campo, a Cagliari per il turno di campionato. Servono altri punti per ipotecare la...
Tra due giorni bianconeri di nuovo in campo, a Cagliari per il turno di campionato. Servono altri punti per ipotecare la...



 Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
Andrea Bosco ha lavorato al “Guerin Sportivo“, alla “Gazzetta dello Sport“, al “Corriere d'Informazione”, ai Periodici Rizzoli, al “Giornale“, alla Rai e al Corriere della Sera.
 Su Corsport: I nodi di Danilo, Bremer e Rabiot.Qualche partenza sarà necessaria se non addirittura salvifica per il bilancio, altre saranno invece piuttosto dolorose. Capitan Danilo, ad esempio, ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe andar via dalla Juve...
Su Corsport: I nodi di Danilo, Bremer e Rabiot.Qualche partenza sarà necessaria se non addirittura salvifica per il bilancio, altre saranno invece piuttosto dolorose. Capitan Danilo, ad esempio, ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe andar via dalla Juve...
 SZCZESNY 6.5 - Si toglie lo smoking con l'intervento su Sanabria, poi è ordinaria amministrazione. Il Toro decide di incornarlo con Masina quasi a fine partita, ma Tek non lo abbatti nemmeno con una gomitata.
GATTI 6 - Sfida nella sfida, visto che il...
SZCZESNY 6.5 - Si toglie lo smoking con l'intervento su Sanabria, poi è ordinaria amministrazione. Il Toro decide di incornarlo con Masina quasi a fine partita, ma Tek non lo abbatti nemmeno con una gomitata.
GATTI 6 - Sfida nella sfida, visto che il...
 Ogni sabato la redazione di Tuttojuve.com analizza i temi caldi del nostro calcio con una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano, Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport. Ecco il suo intervento:
"L’esclusione della Juve...
Ogni sabato la redazione di Tuttojuve.com analizza i temi caldi del nostro calcio con una delle firme più autorevoli del giornalismo sportivo italiano, Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport. Ecco il suo intervento:
"L’esclusione della Juve...
 L'Italia Under 19 è stata sorteggiata oggi a Belfast nel Gruppo A dell'Europeo di categoria. Insieme agli Azzurrini nel girone ci saranno l'Irlanda del Nord, la Norvegia e l'Ucraina. Pafundi e compagni proveranno dunque a difendere il titolo...
L'Italia Under 19 è stata sorteggiata oggi a Belfast nel Gruppo A dell'Europeo di categoria. Insieme agli Azzurrini nel girone ci saranno l'Irlanda del Nord, la Norvegia e l'Ucraina. Pafundi e compagni proveranno dunque a difendere il titolo...
 13:23 - ALLENAMENTO TERMINATO- La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Cagliari. Miretti ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo che ieri è rimasto in piscina per un fastidio all'alluce. Milik, invece,...
13:23 - ALLENAMENTO TERMINATO- La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Cagliari. Miretti ha ripreso ad allenarsi regolarmente in gruppo dopo che ieri è rimasto in piscina per un fastidio all'alluce. Milik, invece,...
 Ancora una volta è il caso di evidenziare un trattamento diverso tra la Juventus e le altre squadre. Da una settimana si parla del caso Acerbi -Juan Jesus e non abbiamo ancora capito cosa sia stato detto dal difensore dell'Inter e chi a questo punto stia dicendo...
Ancora una volta è il caso di evidenziare un trattamento diverso tra la Juventus e le altre squadre. Da una settimana si parla del caso Acerbi -Juan Jesus e non abbiamo ancora capito cosa sia stato detto dal difensore dell'Inter e chi a questo punto stia dicendo...